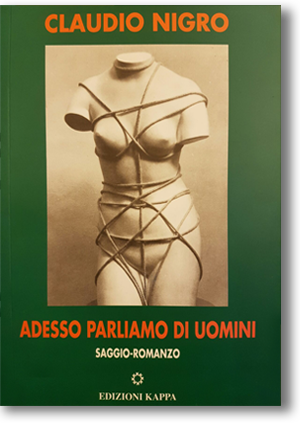
 Andante con
brio
Andante con
brioMolto presto mi si rivelò la coscienza di non essere geneticamente predisposto alla fede, di non avere un punto fisso di riferimento. Avevo poco più di tre anni quella sera del cinque gennaio che andai a letto e rimasi sveglio ad attendere la befana, sapendo già chi fosse: quando tutto tacque e fu buio nella casa, sentii in camera, dove dormivo insieme a mia sorella, il clic della serratura e subito dopo lo stropiccio di carte e il fruscio di vesti emananti l’odore di mia madre da cui l’essere mio era tutto quanto allertato. Tirai su le coperte, dilatai i sensi e mi disposi a percepire i passi circospetti e il brillio dei pacchi intravisti nello sgabuzzino in fondo al corridoio dove erano stati nascosti; appena Mamma fu accanto al mio letto, sentì il calore della sua carne.
La Befana fu la prima di una serie di scoperte: a mano a mano che la realtà mi si rivelava diversa dalle apparenze, il mio sguardo crebbe e s’allungò, come il naso di Pinocchio. A cinque anni scoprii la solitudine e la malinconia; facevo domande, ma non attendevo risposte; provavo solo il piacere per l’imbarazzo in cui mettevo le persone davanti alla richiesta della verità, sicuro che me l’avrebbero negata. Risparmiai solo mia madre, quando i miei occhi caddero sul pancione: sapevo benissimo che avrebbe partorito un bambino e che non aveva tempo da perdere con cicogne e cavoli per inventare stupidi stratagemmi a questioni così importanti. Questo modo di essere probabilmente mi avrebbe procurato l’infelicità, se non avessi sviluppato in tempo il desiderio di contatto con gli altri che presto mi condusse a un uso crescente e incontrollato della parola.
