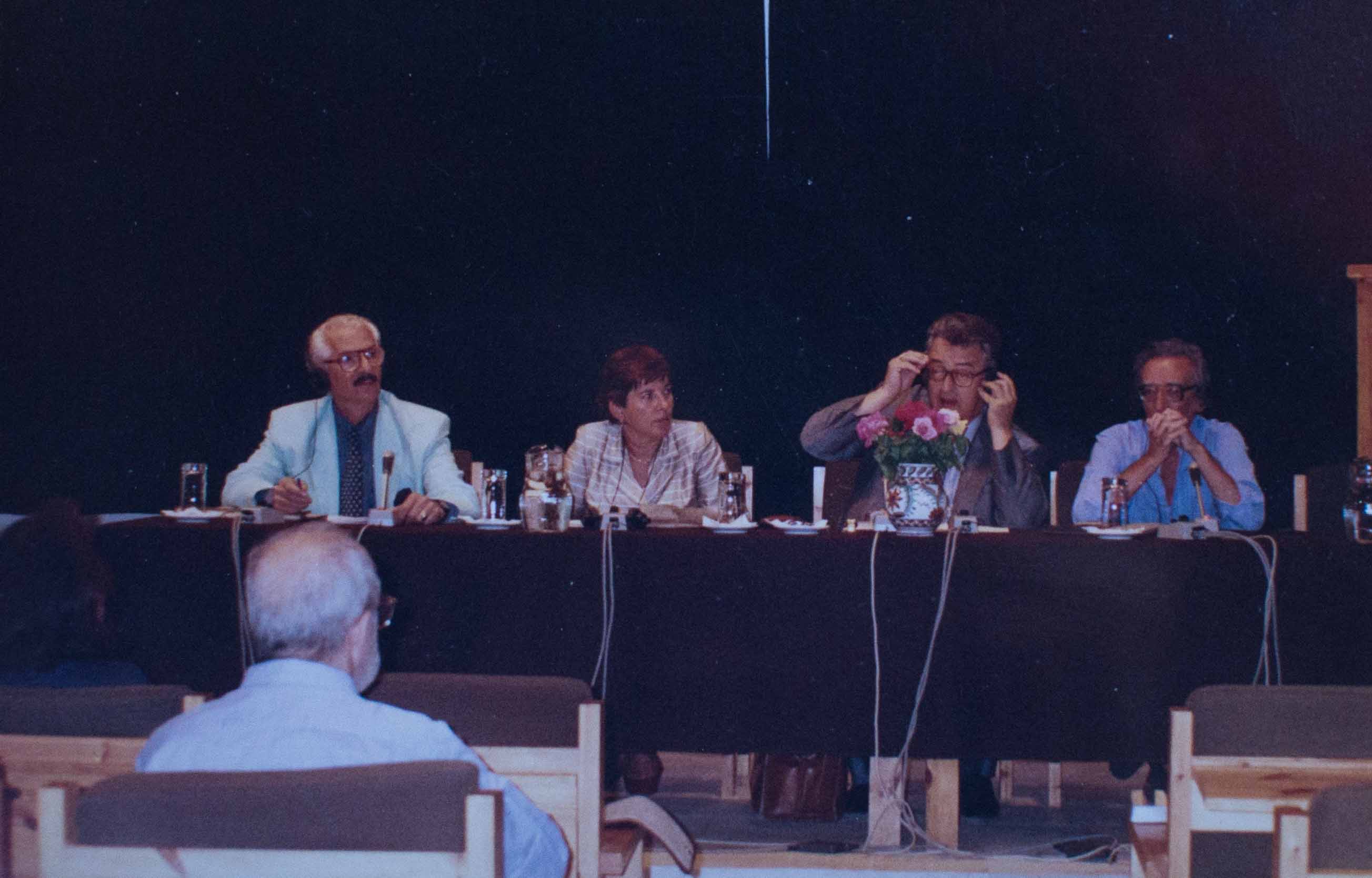 Tralasciando questioni di massima sulla particolare situazione storica e politica della Grecia -questioni che ci spingerebbero molto indietro nel tempo, almeno alla caduta di Costantinopoli e alla turcocrazia- e venendo ai tempi più recenti -difficilissimi tempi, che hanno visto la Grecia libera dal 1821, ma segregata dall’Occidente e in un travaglio senza uguale nella ricerca di un’identità culturale svincolata dall’ipoteca del suo glorioso passato, la cui contemplazione ha segnato numerose battute d’arresto sul cammino dell’emancipazione-, fermiamo l’attenzione sul tema che qui cerchiamo di affrontare, ponendo subito la domanda: che cosa ha prodotto la Grecia di oggi in letteratura? O meglio: che cosa è stato esportato, o importato e tradotto in Italia dei suoi prodotti letterari? Proveremo a rispondere con un giro di proposizioni.
Tralasciando questioni di massima sulla particolare situazione storica e politica della Grecia -questioni che ci spingerebbero molto indietro nel tempo, almeno alla caduta di Costantinopoli e alla turcocrazia- e venendo ai tempi più recenti -difficilissimi tempi, che hanno visto la Grecia libera dal 1821, ma segregata dall’Occidente e in un travaglio senza uguale nella ricerca di un’identità culturale svincolata dall’ipoteca del suo glorioso passato, la cui contemplazione ha segnato numerose battute d’arresto sul cammino dell’emancipazione-, fermiamo l’attenzione sul tema che qui cerchiamo di affrontare, ponendo subito la domanda: che cosa ha prodotto la Grecia di oggi in letteratura? O meglio: che cosa è stato esportato, o importato e tradotto in Italia dei suoi prodotti letterari? Proveremo a rispondere con un giro di proposizioni.
Se entriamo in una grande libreria di Roma, per esempio, Rizzoli, Feltrinelli, Einaudi, e chiediamo un testo di narrativa neo-greca, sarà necessaria qualche precisazione; cioè, che non vogliamo né Omero, né Sofocle, né i lirici greci e neppure i poeti moderni, Ritsos, Kavafis, Elitis (anche questi, in verità, presenti in proporzioni modeste). Allora, arriverà il direttore, il quale consulterà sul computer il catalogo, dove apparirà sperduto e solitario I Fonissa, (l’Assassina, 1903) di Papadiamantis, edito da Feltrinelli nel 1989. (Apprendiamo che tale pubblicazione seguì all’intesa personale dell’allora ministro della Cultura, Melina Mercouri, con la vedova Feltrinelli). Però, frugando tra gli scaffali nel reparto delle letterature straniere, -non esiste un settore specialistico di letteratura neo-greca- salterà fuori una raccolta di Nuovi narratori greci, pubblicata di recente da Theoria, una casa che si occupa di opere poco conosciute. Dei circa 150 titoli tradotti in italiano dal 1940 a oggi se ne conserva soltanto memoria bibliografica nelle case editrici più note; ma ci sorprende che non sia stata ripubblicata una pregevole raccolta di saggi di Giorgio Seferis, Le parole e i Marmi, edito da Il Saggiatore nel 1965 a cura dell’infaticabile Pontani -ripresa e arricchita in una edizione di lusso della UTET, nel 1971-, un’opera di attualità degna di riproposta, come le opere di Blanchot e della Nouvelle Critique, dove, fra l’altro, sono messi in rapporto dialettico i concetti di lingua e di linguaggio per riproporre allo scrittore moderno il problema della necessità di prendere le distanze dai Padri, senza rinnegarli – problema, del resto comune a tutta la civiltà dell’occidente- ed avviare un lavoro di scavo nel linguaggio corrente per imprigionarne il flusso sanguigno e mutevole in forme consustanziate di vita. (Di sfuggita, ricorderemo di Seferis il suo affettuoso omaggio al luogo dove ci troviamo, a Delfi, che per volger di eventi e di idealità, ha conservato integra, fin dai tempi di Plutarco, la sua maestosa sacralità, avendo catturato in qualche parte -come nella leggenda celtica-, lo spirito dei suoi numi tutelari).
Potremmo considerare completo il risultato delle nostre ricerche, se non ci fosse capitato di scorgere tra le novità sul bancone della libreria Feltrinelli “El Greco (Lo sguardo cretese)” di Nikos Kazantzakis – edito da Il Vascello e uscito in Aprile- del quale, apprendiamo per chiarirci meglio le idee, si sono vendute sei copie .
Ma non terminerò la mia sommaria rassegna senza aver ricordato l’ambiziosa iniziativa -di cui mi è giunta da poco notizia- di una casa fiorentina, Alitheia, che si sta preparando ad una grande penetrazione in Italia della cultura neo-greca con un catalogo rispettabile che abbraccia storia, pittura, musica, architettura e letteratura, per la quale è stato già pubblicato il romanzo To triti sfefàni (Il terzo anello) di Kostas Tachtsis, ed è in preparazione To diplò vivlio (Il doppio libro)di Dimitri Katsì.
Passiamo, ora, alle considerazioni d’obbligo. Se si chiede una copia di I Fonissa, sarà difficile averla, perché l’edizione invenduta è stata ritirata e non si è provveduto alla riproposizione. Eppure, la critica italiana, specialmente quella giornalistica, accolse con favore un’opera che rivelava, assieme al retaggio del mito greco, un solido impianto sociologico e una potente struttura narrativa: il tema della condizione della donna schiava del maschio riesplode nella lacerante e allucinata ribellione della protagonista, la levatrice Chadula, che combatte da sola per sottrarre alla società le neonate femmine, schiave predestinate da un’inattaccabile mentalità, e restituire loro la libertà con la morte, sfidando le leggi degli uomini per affidarsi direttamente al giudizio di Dio. I Fonissa è un romanzo che potremmo inserire nella “letteratura della rivolta”, dove il senso della vita non è nella descrizione diretta dell’esperienza, ma nel suo essere una macchina interpretativa attivata da un motore che travolge la storia e il mito per risalire alle fonti perenni del dolore umano, fonti scaturite insieme all’atto costitutivo del genere umano per porsi come una minaccia a ogni ordine stabilito.
Dunque: che cosa è accaduto perché il libro di Papadiamantis non vedesse la riedizione, come accade per le opere francesi, inglesi, americane, tedesche, etc.? Non dico le 49 edizioni che si sono fatte in Italia dal 1973 ad oggi di Siddharta, di H. Hesse, ma una riedizione che servisse a rinfrescare la memoria dei più lenti alle proposte editoriali e che cercasse di porsi come un punto di partenza per la letteratura greca moderna. Purtroppo, la situazione in cui si trova il lettore italiano davanti alla narrativa greca, la chiarisce molto bene nell’introduzione la curatrice della raccolta Nuovi narratori greci: quella di un lettore medio che della Grecia conosce soltanto notizie di attualità mondane e scandalistiche (diciamo pure che la storia con il tempo è andata a confondersi con il gossip, dovunque) e che, perciò, ha bisogno di essere stimolato, coinvolto, perché non si senta spaesato nella “terra di nessuno”. Questo non ci ha confortato, ma è servito a spiegarci le ragioni per cui i Fonissa è tornata nel dimenticatoio, come tanti altri romanzi greci.
La lodevole iniziativa di Alitheia sembra già destinata al circuito universitario, cioè, per gli addetti ai lavori, e quindi, non di ampia diffusione presso il grosso pubblico che, si sa, preferisce le “marche” più note. D’altronde in libreria non ne è giunta una vasta eco. Intanto, in Grecia, le produzioni e le edizioni si susseguono a ritmo incalzante.
Certo, la Grecia non è letterariamente la Francia e non ha avuto il suo Proust, o il suo Balzac, né il suo Voltaire, né il suo Montaigne. Tuttavia, ci sono note, per esempio, le difficoltà che incontrò Proust, e proprio in Francia, dove il direttore della Gallimard, André Gide, pare non leggesse neppure il manoscritto della Recherche (lo afferma Proust stesso, ricavando la certezza da un nodo con cui aveva legato il plico rimasto tale e quale). Ma conosciamo anche la tenacia dei Francesi nel costruire i loro miti all’interno e all’estero, soprattutto dopo la morte liberatoria di esistenze spesso imbarazzanti e oltre le regole sociali: così, la battaglia che stanno ancora combattendo per la diffusione di L.F.Céline, lo scrittore compromesso con il nazismo (prima o poi finirà nelle liste della Resistenza!), il cui talento negli anni a venire sconvolgerà i martirologi letterari; così, il riconoscimento letterario di Jean Genet, l’uomo dalla vita irregolare, il Saint Genet commediografo e martire, apprezzato per primo da Sartre e ormai in decollo su scala mondiale. In verità, la Francia si è spinta oltre -forse, anche troppo-, giungendo fino a una sorta di nazionalizzazione degli eventi culturali, anche di quelli avvenuti fuori dai suoi limiti territoriali!
Ma, torniamo in Grecia. Che cosa ha fatto perché la proposta di uno scrittore come Papadiamantis non restasse un fatto unico e precario, legato solo alla buona volontà della Mercouri? Che cosa sta facendo, ora, per far conoscere scrittori moderni, come Chimonàs, Tachtsìs, Chatsì? Che cosa fa l’Italia?
Diciamo che l’Italia e la Grecia, due paesi di grandi tradizioni storico-culturali, sono oggi legati prevalentemente da un massiccio turismo unidirezionale che vede riversarsi sulle coste elleniche orde italiche in camper (quei brutti contenitori di umani e di brutte abitudini) e in orridi abbigliamenti, attratti dalla propaganda commerciale e convinti -gli indegni eredi di Byron- che la Grecia sia soltanto mare, taverne, cattedrali nel deserto. I rapporti culturali sono intrattenuti dalle cattedre universitarie distanti dalle masse. Non ho mai avuto notizia di iniziative che vedessero per esempio, scrittori italiani e greci a confronto. Tra le tante compagnie teatrali (oltre trecento) che si sono costituite quest’anno non una sola proposta di una pièce greca: ricordo tanti anni fa solo un monologo di Ritsos in un teatrino di Trastevere. Il cinema di Anghelopoulos è cinema di élite e in Italia gira soprattutto nei circuiti di essai. Del grande direttore d’orchestra Dimitri Mitropoulos si sono diffusi solo pettegolezzi scandalistici, mentre la Germania costruiva il mito di von Karajan, quando questi era poco più di un neonato. Il fenomeno Maria Callas, allieva del Conservatorio di Atene, è stato gestito all’estero e la Grecia lo ha importato in proporzioni ridotte e con entusiasmi molto contenuti. I musicofili ricorderanno la triade greca Callas-Minotis-Tsaroukis nella Medea di Cherubini rappresentata nel 1961, prima nell’anfiteatro greco di Epidauro e poi alla Scala di Milano: lo spettacolo, però, era americano.
Se si sfoglia un manuale italiano di Storia del Teatro, difficilmente vi troveremo rappresentata la Grecia; e questo molto ingiustamente, poiché esistono ad Atene un museo ed una biblioteca teatrale di tutto rispetto, con ampie documentazioni di grandi compagnie greche (p.es. di Minotìs e di Paxinoù) e di grandi interpretazioni, come quella di Elena Papadàkis (nel ruolo di Ersilia Drei in Vestire gli ignudi) degna della fama di Eleonora Duse e di Sarah Bernardt. E non solo. Ho letto di recente un interessante studio di Alkistis Proiou e di Angela Armati dell’Università di Roma sulla diffusione di Pirandello, fin dal 1914, in Grecia, dove attualmente è presente anche il teatro di Dario Fo.
La televisione -non solo quella italiana-, dove passa tutto, ignora la Grecia, ma, quando occorre, le affibbia qualche banale immagine di folklore contraffatto. La frenetica imprenditoria editoriale italiana che pubblica e ripubblica senza tregua opere straniere, insiste, purtroppo, su posizioni di esagerata riservatezza davanti alle opere greche.
Certo, l’Italia non è il paese delle avanscoperte, e dunque, è la meno autorizzata a muovere critiche ai Greci per la scarsa solerzia nel diffondere la loro cultura: a parte il caso di Italo Svevo, solo da poco scoperto, si pensi alla situazione di P.P.Pasolini che probabilmente sarebbe stato relegato nei circuiti cinematografici, dimenticato come scrittore appassionato e moderno nel senso in cui lo intendeva il compianto Elias Canetti. Ce lo ha restituito “bello di fama e di sventura” la Francia. Un caso diverso -diciamo pure, un’operazione commerciale ben calcolata-, ma ugualmente emblematico, è stato quello di Umberto Eco: Il nome della rosa è rimbalzato in Italia trionfalmente solo dopo che è divenuto un best-seller in America. Se, allargando il discorso, proviamo a porci la domanda: chi è il destinatario italiano a cui la produzione letteraria neo-ellenica può rivolgersi, la risposta è desolante, perché si tratta di un lettore senza sapere, senza passione, allineato nei gusti al disimpegno e alla facilitazione, un lettore che ha potuto permettere il successo, prima, a Io speriamo che me la cavo, un becero assemblaggio di balbettii infantili e, poi, a Va, dove ti porta il cuore, un’indigestione di banalità con rigurgiti e ruttini di sentimentalismi démodé.
Ma, veniamo alle conclusioni, ponendoci subito una domanda: che cosa può rendere oggi necessaria la traduzione e la diffusione degli autori neo-greci in Italia? Alla quale rispondiamo: l’ufficializzazione di un dato di fatto, lo stesso che ha reso così ricca la fioritura degli scrittori latino-americani da noi; cioè, una stretta correlazione tra cronaca, letteratura e storia, la storia greca in cui costantemente aleggia il mito e il simbolo, veicoli sicuri di ritorno a verità primordiali. I romanzi greci dell’ultimo trentennio sono romanzi del dialogo, dove l’esperienza è affidata alla scrittura che disperatamente combatte per omologare nuove tragedie ad antichi dolori, in un presente dilaniato da profonde ferite sociali, che, usando un’espressione sartriana, “la letteratura deve ricucire”, ma non senza averle prima riaperte in tutto il loro sanguinare. Ecco la lotta ingaggiata dallo scrittore moderno che, seguendo l’efficace immagine baudelairiana, è un duello con le parole, con il linguaggio, per trarne forme espressive tese, che sfruttando tutte le possibilità della lingua greca, sia capace di dar vita alle passioni, alle ansie, alle attese, alle fobie, infine, all’identità di un popolo alla ricerca di un metodo di svezzamento politico e culturale dal suo passato, liberato finalmente dall’isolamento, cui lo ha condannato il privilegio di usare ancora la lingua dei nostri Padri.
Concludo con l’auspicio che Grecia e Italia, due paesi così vicini, così simili, così ricchi di storia, lavorino con tutti i mezzi possibili e impossibili, leciti e illeciti, per far cadere diffidenze e barriere letterarie e culturali con un costante flusso di opere dall’una all’altra lingua e con iniziative che rivitalizzino il rapporto fra le due antiche civiltà, legate da sempre da un cordone ombelicale. E chissà che da un tale flusso di energie non esploda un corto circuito in cui restino fuse Roma e Atene su un asse preferenziale intorno al quale far ruotare tutta la compagine mediterranea in nome dei riscoperti valori morali e simbolici, -e, perché no? economici-, che furono all’origine della più grande civiltà occidentale. (Conferenza tenuta a Delfi, il 27 Agosto ‘94)
